
Il tiro contro-costa è definito in ambito NATO come Naval Surface Fire Support (NSFS), e precedentemente come Naval Gunfire Support (NGFS), considerato ormai come un sotto-insieme del primo, visto che per il NSFS vengono impiegati non solo i cannoni, ma anche missili e altre soluzioni.
Il confine tra NSFS e gli attacchi dal mare (strike) non è sempre così netto e definito, tanto che talvolta vengono impiegati gli stessi strumenti. In linea di principio, gli strike avvengono spesso (ma non sempre) su obiettivi predefiniti posti più all’interno, rispetto a quelli sulla costa. Al contrario, il NSFS è maggiormente rivolto a fornire un supporto di fuoco su chiamata a reparti da sbarco o a sostenere le forze sul fronte terrestre, affiancando o sostituendo l’azione delle artiglierie di questi stessi reparti e/o il supporto aereo ravvicinato fornito dagli aerei ed elicotteri d’attacco imbarcati. La pubblicazione statunitense JP 3-09.3 Joint Fire Support, nell’ambito del NSFS comprende eventualmente anche operazioni di guerra elettronica e la difesa anti-aerea e anti-missile a favore delle truppe a terra, ma queste attività hanno caratteristiche molto diverse e non verranno quindi trattate in questa sede.
Naturalmente tale supporto di fuoco richiede una risposta molto veloce: gli attuali requisiti indicano un tempo di 150 secondi tra la richiesta di supporto e la risposta (forse un po’ troppo ottimistico…), e di conseguenza un collegamento robusto e affidabile tra gli elementi a terra e quelli imbarcati. Nel caso di un’operazione anfibia, i reparti a terra o gli osservatori avanzati inviano la richiesta al comando dell’operazione (CATF-CLF) che si trova su una LHA o LHD, e quest’ultimo, tramite una delle sue agenzie, passa i dati ad uno o più “shooters”, tipicamente un cacciatorpediniere o un’altra unità navale destinata a questo ruolo.
Il tiro contro-costa è stato sempre una presenza costante nei manuali d’artiglieria navale. Da secoli le navi da guerra hanno attaccato installazioni costiere, e nella 2a Guerra Mondiale hanno rappresentato l’indispensabile cornice di innumerevoli sbarchi, tanto in Europa quanto nel Pacifico, così come attacchi condotti dal mare contro obiettivi terrestri. Vi sono state analoghe operazioni di NSFS anche durante la Guerra di Corea e la Guerra del Vietnam e alle Falkland. In epoca più recente il ricorso al NSFS è stato molto meno rilevante (Libano, Somalia, Iraq, Libia, Gaza). Le difese costiere oggi hanno capacità tali da mettere a repentaglio la sopravvivenza di un gruppo navale che si avvicini a decine, se non centinaia, di chilometri dalla costa. Per questa ragione è oggi semplicemente impensabile tornare a pianificare grandi operazioni anfibie contro un nemico tecnologicamente avanzato e preparato a difendersi da un’invasione dal mare. Restano tuttavia possibili diversi tipi di operazioni anfibie: dagli sbarchi contro gruppi di insorti o terroristi ai veloci raid e alle operazioni speciali, dall’evacuazione di civili da aree di conflitto alla creazione di una cornice di sicurezza per interventi di stabilizzazione o per operazioni umanitarie. In tutti questi casi si tratta dunque di operazioni caratterizzate da un basso livello di minaccia verso le navi.
Di conseguenza è anche diverso il tipo di supporto di fuoco ipotizzabile. Un tempo le artiglierie navali dovevano essere in grado di sparare centinaia di colpi, anche per appoggiare l’avanzate delle truppe sbarcate, costringendo i difensori a mettersi al riparo, così come per effettuare fuoco di contro-batteria o per distruggere bunker e centri di resistenza nemici. Ciascuno dei numerosi cacciatorpediniere disponeva abitualmente di 4 o 6 cannoni da 127/38, potendo quindi offrire una cadenza complessiva di circa 60 colpi/minuto. La disponibilità di munizionamento di precisione - artiglierie o missili - consente di sparare meno colpi (“fire for effects”) ottenendo in teoria i medesimi risultati. Tuttavia sussistono problemi rilevanti. Uno di questi è la gittata: il munizionamento tradizionale dei cannoni da 127/54 arriva a 24 km, ovvero una distanza così bassa da mettere seriamente a rischio la nave anche solo con il fuoco di una “banale” bocca da fuoco terrestre da 155 mm che può raggiungere 30-40 km, per non parlare di portate molto maggiori offerte dai razzi guidati o dai missili antinave costieri. Alle artiglierie navali si sono poi aggiunte altre tipologie di armi idonee a colpire il territorio avversario, tanto sulla costa quanto in profondità, sfruttando alcune caratteristiche intrinseche delle forze navali: mobilità, permanenza, flessibilità.
Negli Stati Uniti la nuova dottrina Joint All-Domain Command and Control (JADC2), rilasciata nel 2022, e spesso sintetizzata nello slogan “any sensor, any shooter”, prevede appunto che tutte le forze debbano poter contribuire sia alla propria difesa, sia alla capacità di colpire in profondità all’interno dell’area di operazioni avversaria. Per quanto riguarda le Marine, ciò si traduce nel modo in cui le forze navali possono sostenere le operazioni sul fronte terrestre, oltre che sulla costa. Questo riguarda quindi non solo il supporto alle operazioni anfibie, ma anche il contributo alla soppressione delle difese aeree nemiche a terra e l’apertura di varchi nelle “bolle” A2/AD.
Esamineremo quindi le soluzioni esistenti o in sviluppo per le diverse classi di sistemi d’arma che oggi possono contribuire alle missioni di NSFS.
L’articolo completo è pubblicato su RID 5/25, disponibile online e in edicola.
Seguiteci sui nostri canali Telegram, Facebook, X e YouTube.




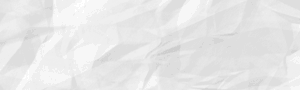


.gif)

