
Dopo la “battaglia dello Studio Ovale” con Zelensky, che ha lasciato morti e feriti nel campo occidentale, si può parlare ancora di un razionale dietro la condotta di Trump? Quali sono gli interessi che spiegano le sue scelte? Sono veramente quantificabili? Oppure Trump è il rottamatore dell’Occidente, al soldo ovviamente dello Zar?
Ora, al di là dei bias e delle euristiche, sempre determinati nei momenti di grande emozione e confusione informativa, proviamo a rispondere a queste domande cercando di essere il più possibile razionali e sostenibili.
Dunque, partiamo da un assunto che si basa su un dato empirico fondamentale. Secondo il Congressional Budget Office (CBO), dal 2024 il costo del debito federale americano, ovvero la spesa per il pagamento degli interessi, ha superato il budget del Pentagono: 882 miliardi di dollari che, sempre secondo il CBO, quest’anno potrebbero crescere a 952 miliardi di dollari, per sfondare quota 1.000 miliardi nel 2026. Le proiezioni per i prossimi 10 anni ci mostrano un deficit sistematicamente superiore al 6% del PIL e un debito federale che oltrepasserà quota 120% sul PIL. Insomma, gli USA hanno un problema, che non è contingente, bensì strutturale, e che a che fare con la capacità di continuare ad assicurare i livelli di spesa pubblica necessari ad alimentare la loro primazia militare e, contemporaneamente, ed a fornire le stesse performance nel campo dell’assistenza sociale, medica, ecc., con l’erogazione dei relativi servizi.
Ecco, allora, spiegata l’intenzione dell’Amministrazione Trump, condivisa da una parte non trascurabile dell’establishment politico americano, di ridurre la spesa militare premendo allo stesso tempo sugli alleati europei affinché siano loro a spendere di più per la Difesa. Un modo per cercare una compensazione ed assicurare un più equilibrato burden sharing, cercando di sfuggire ad una trappola che, prima o poi, scatterà.
È chiaro che questo passaggio è strettamente legato ad una revisione dell'ordine internazionale. Un ordine basato sull’egemonia liberale americana, per come questa si è definitivamente affermata dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che, secondo l’Amministrazione Trump, ha oggi un costo che ha superato il beneficio di cui l’America e l’Occidente hanno goduto per più di 70 anni. Da qui, l’obiettivo di chiudere in qualche modo la partita ucraina, allentando la conflittualità con la Russia e scaricandola in buona parte sugli alleati europei, e di provare a resettare i rapporti con Mosca in nome di quel pragmatismo “economicistico-commerciale” che da sempre costituisce il marchio di “casa Trump”. Questo “riavvicinamento” servirebbe, ecco il secondo passaggio, anche ad evitare che si saldi definitivamente il blocco geopolitico euroasiatico tra la Russia e la Cina, che è andato consolidandosi negli ultimi anni e che costituisce una minaccia per un “impero di mare” come quello americano. In questo esercizio “neo-kissingeriano”, il revisionismo trumpiano farebbe affidamento sul fatto che Mosca non muore certo dalla voglia di restare tra le braccia del Dragone, ma preferirebbe mantenere le proprie mani libere, cercando pure di riaprire alcuni canali con lo stesso Occidente.
Nel complesso, dietro le scelte di Trump ci sarebbe una logica strategica abbastanza chiara che mirerebbe, appunto, alla creazione di un sistema basato sulla concertazione tra grandi potenze - Stati Uniti, Russia e Cina - con un ruolo secondario per l'Europa, che si punterebbe a dividere utilizzando il tradizionale strumento delle relazioni e dei partenariati bilaterali. Un mondo a geometria variabile, vecchio stampo, dominato da logiche di potenza e dove il grande regolatore della vita internazionale tornano ad essere i rapporti di forza.
Seguiteci sui nostri canali Telegram, Facebook, X e YouTube.
(immagine: estratto del video pubblicato sui social POTUS)




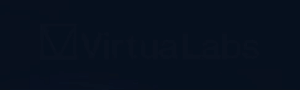


.gif)

