.jpg)
Il contesto globale nel quale viviamo è divenuto straordinariamente complesso. Il secolo scorso si era chiuso con la speranza di un sistema globale di convivenza pacifica, ma i fatti hanno dimostrato che cosi non sarà. Aree apparentemente stabili sono diventate luoghi di atrocità e di crimini contro l’umanità al riaccendersi di conflitti che con la Guerra Fredda parevano sopiti.
La globalizzazione ha portato ricchezza e sviluppo in molte aree, ma ha creato anche disparità sociali, trasferimenti di ricchezze e di strumenti di produzione. L’aspirazione a modelli sociali democratici ha plasmato una nuova generazione di persone, ma ha anche dato il via alla rinascita dei nazionalismi, all’intolleranza, e ai conflitti per le risorse primarie.
La rivoluzione delle tecnologie e dell’informatica sembrava offrire all’umanità la possibilità di ottenere di più dal pianeta, ma oggi deve confrontarsi con la evidenza della insostenibilità di modelli economici basati sullo sfruttamento intensivo delle risorse.
La recente invasione Russa dell’Ucraina, poi, ha dimostrato che le dinamiche di guerra tra Stati, apparentemente superate, sono ancora presenti nel ventaglio delle scelte politiche disponibili e che le stesse aprono a possibilità di escalation non facilmente governabili. L’evoluzione geopolitica da un sistema sostanzialmente unipolare ad uno multipolare, peraltro, sembra accentuare questo modello di conflittualità interstatuale.
Il nuovo Concetto Strategico della NATO e il rinnovato sforzo dell’Unione Europea verso una “dimensione Difesa” più solida rispetto al passato, sono segnali del passaggio da una situazione caratterizzata da minacce diffuse (terrorismo, integralismo, instabilità) verso una che purtroppo non esclude la possibilità di conflitti distruttivi ad alta intensità e non relegati alla sola dimensione militare, ma estesi anche a settori sensibili per la sopravvivenza delle popolazioni (energia, cibo, risorse primarie, etc.).
Il Mediterraneo e la Sicilia, si trovano al centro di questa ondata di cambiamenti storici, culturali, economici. Senza voler andare lontano nel tempo, la centralità geopolitica dell’Isola, sita al centro dello specchio d’acqua che separa l’Eurasia e l’Africa, è provata almeno dal 1869, anno dell’apertura del Canale di Suez. Dalla Trinacria si controlla lo Stretto di Sicilia dal quale passano le rotte che collegano l’Atlantico all’Indo-Pacifico. Il controllo della Sicilia è, e rimarrà centrale nella partita tra Stati Uniti e Cina, ma non solo (India, Turchia). Wolfgang Goethe diceva: “La Sicilia è la chiave di tutto”. Non è un caso l’interesse cinese per l’isola manifestatosi addirittura con la presenza di Xi Jinping a Palermo nel marzo 2019.
La Sicilia è inoltre centrale per l’Europa in 2 settori che abbiamo riscoperto come vitali: le comunicazioni e l’energia. In Sicilia, infatti, arrivano dall’Africa 2 importanti gasdotti ed è anche snodo nevralgico per le comunicazioni da e per il Medio Oriente e il nord Africa. Davanti le coste siciliane è posizionato il Flag (Fiber-Optic Link Around the Globe) su cui viaggiano dati dall’Inghilterra al Giappone. A Palermo è presente un data center neutrale della Sparkle collegato a 18 cavi internazionali che fornisce connettività avanzata tra Medio Oriente, Africa e gli hub europei.
Ma la Sicilia è rilevante anche per la difesa europea e i rapporti transatlantici, in quanto ospita a Sigonella una delle basi americane più importanti al mondo, a Niscemi insiste il Muos (Mobil User Objective Sistem) parte di un sistema globale e che consente comunicazioni sicure per l’Europa, il Mediterraneo e il continente africano. Inoltre, Lampedusa è sede di un importante osservatorio radar, mentre ad Augusta vi è uno strategico porto militare.
Infine, nel triangolo Priolo, Melilli, Augusta vi è uno dei poli chimici più importanti d’Europa, mentre altre raffinerie sono presenti a Gela e a Milazzo.




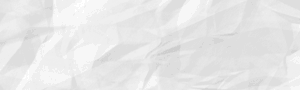
 scarica il file
scarica il file

.gif)

